Il nome delle cose
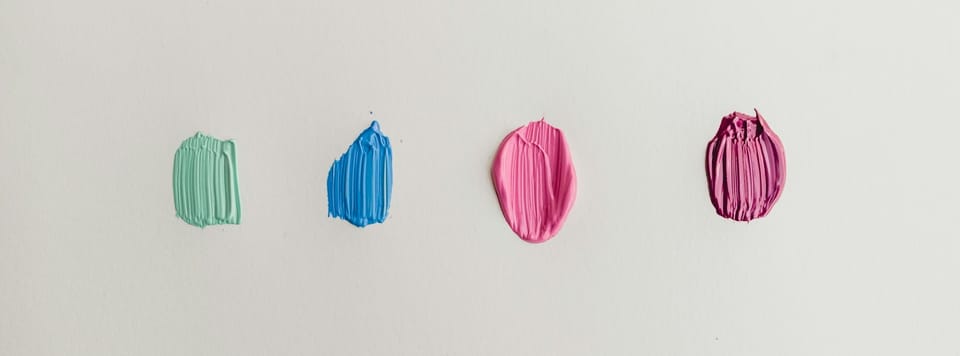
Se stai leggendo queste righe, vuol dire che alla fine sono riuscita a mettere in ordine i pensieri e a far partire il primo numero di Sommersə. Sono mesi che penso a questa newsletter: a come chiamarla, da dove partire, a cosa raccontare e come. Ed ora eccomi qui, imbambolata da oltre un’ora davanti allo schermo del mio portatile, completamente incapace di mettere in fila due parole.
Fino a qualche mese fa, un blocco del genere mi avrebbe fatta infuriare. Avrei cominciato a girovagare disperata da una stanza all’altra della casa, incolpandomi e cercando di obbligare il mio cervello annebbiato a partorire qualcosa. Qualsiasi cosa, a patto di scacciar via l’intollerabile nervosismo pruriginoso che mi prende quando testa e dita non rispondono come vorrei. Sarei poi probabilmente finita a letto, con gli occhi incollati al soffitto e le tempie pulsanti, nel tentativo di calmare un’imminente crisi – di nervi o esistenziale, ma spesso un bel cocktail frizzantino di entrambe. A fine giornata, avrei avuto la sensazione di non aver concluso niente, di aver perso un sacco di tempo prezioso. Sarei andata a dormire amareggiata, arrabbiata con me stessa, sentendomi inutile e incapace.
Oggi va diversamente. Lo ammetto: una piccola crisi c’è stata, ma più breve e gestibile. Non mi sono auto-flagellata (ok, forse solo un po’). Mi sono presa del tempo, mi sono data spazio e modo di fare piccoli aggiustamenti che permettessero a corpo e mente di distendersi.
A volte funziona, a volte no. È un po’ come cercare di decifrare un marchingegno complesso senza il libretto delle istruzioni, procedendo per tentativi. Ero convinta di conoscermi, ma mi sbagliavo di grosso. Ho 32 anni e sto cominciando solo ora a scrivere il mio personalissimo, disordinato libretto delle istruzioni.
Neurodivergenze, autismo e tutto quello che non sapevo
La prima volta che ho sentito parlare di neurodivergenze in maniera approfondita è stata l’anno scorso. Per quanto avessi sempre avuto il sospetto che la mia depressione e la mia ansia fossero sintomi di qualcosa di più profondo e radicato, non avevo mai nemmeno lontanamente considerato l’ipotesi di poter essere neurodivergente. E anche se la descrizione dell’esperienza neurodivergente mi suonava familiare, ancora non riuscivo ad orientarmi. Era tutto troppo vago e confuso.
Diversi mesi dopo, il mio compagno è stato diagnosticato ADHD. Più parlavamo di ciò che stava scoprendo grazie alle sue ricerche e alla terapia, più quella sensazione di familiarità cresceva. Eppure, non tutto tornava: benché avessimo tratti in comune, in molti campi le nostre esperienze differivano in maniera significativa.
È stato allora che ho iniziato a leggere, a cercare, a fare e a farmi domande. Tutto sembrava puntare verso una direzione piuttosto precisa: autismo. Ma più approfondivo, più i miei dubbi aumentavano. I criteri diagnostici contenuti nel DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, il manuale utilizzato a livello internazionale per le diagnosi psichiatriche) descrivono infatti l’autismo come un “disturbo”. Una definizione costruita attorno a ciò che manca, a ciò che non funziona. Una lunga lista di deficit e anomalie.
“Deficit? Io? Ma com’è possibile?”, continuavo a domandarmi in preda alla confusione. Pur avendo la netta sensazione di essermi finalmente instradata verso la direzione giusta, quella lista lunghissima di “devianze da correggere” mi lasciava perplessa. Mi ripetevo che, in fondo, ho sempre avuto una vita normale – qualsiasi cosa normale voglia dire, ma di questo ne parleremo più in là.
In quel momento, non mi rendevo conto di essere del tutto sprovvista degli strumenti necessari per fare chiarezza. Ero intrappolata nella visione proposta dal DSM-5 e da gran parte del discorso pubblico, che definisce l’autismo secondo un angusto paradigma medico: una patologia che deriva da uno sviluppo cerebrale “sbagliato”, opposto al processo di neurosviluppo considerato invece “normale”. Secondo questa logica, l’autismo diventa un problema da trattare, mitigare, correggere.
Io stessa ero vittima inconsapevole del paradigma medico. Se da un lato mi riconoscevo in molti dei tratti autistici, dall’altro non riuscivo a far combaciare la mia esperienza con l’immagine stereotipata della persona autistica diffusa dai media. Ero sconfortata, spaventata, e piena di dubbi. Che mi stessi autosuggestionando solo per dare una speigazione ad anni e anni di depressione e ansia?
La risposta ai miei tormenti è arrivata quando mi sono finalmente imbattuta in un tipo di narrazione diversa. Esistono ricercatorə, attivistə, terapeutə neurodivergenti che stanno ridefinendo i concetti stessi di neurodivergenza e autismo a partire dal proprio vissuto. Uno di questә è il Dr. Nick Walker, ricercatore statunitense, che ribalta il paradigma medico inserendo l’aspetto sociale nell’equazione. Neurodivergente è “una persona il cui funzionamento neurocognitivo si discosta dalle norme sociali dominanti in diversi modi”, scrive. Secondo la sua prospettiva, la neurodivergenza non può e non deve essere definita come intrinsecamente negativa. Il giudizio di valore che le viene attribuito dipende piuttosto dal confronto con uno standard rigido e univoco, imposto dalle norme sociali.
Nel definire l’autismo, il Dr. Walker spiega che si tratta di una variante neurologica legata a fattori genetici. Anche se non conosciamo ancora tutti i dettagli, gli studi attuali mostrano che la differenza principale tra le persone autistiche e quelle non autistiche riguarda il modo in cui il cervello è collegato e reagisce agli stimoli. Nei cervelli autistici, le connessioni tra i neuroni sono più numerose e più sensibili. Questo fa sì che chi è autisticә percepisca il mondo in modo più intenso e disordinato: il cervello raccoglie più informazioni, e ogni stimolo – che sia un suono, un’emozione o un pensiero – può avere un impatto più forte e meno prevedibile.
Ma se è vero che esistono tratti neurologici comuni, è altrettanto vero che l’autismo non è un’esperienza uniforme: ogni persona autistica è unica, e il modo in cui vive la propria neurodivergenza dipende da moltissimi fattori – individuali, ma anche e soprattutto sociali e culturali. “Nel contesto di una società progettata intorno alle esigenze sensoriali, cognitive, evolutive e sociali delle persone non autistiche, le persone autistiche sono quasi sempre disabilitate in una certa misura – a volte in modo evidente, altre volte in maniera più sottile”, scrive Walker. “Alla fine, descrivere l’autismo come un disturbo rappresenta un giudizio di valore piuttosto che un fatto scientifico.”
Il paradigma della neurodiversità
Il Dr. Nick Walker fa parte del gruppo di studiosә che hanno articolato il paradigma della neurodiversità. Secondo tale prospettiva, le differenze neurologiche fanno parte della normale variabilità umana, esattamente come altre caratteristiche genetiche. Nel libro The Pocket Guide to Neurodiversity, Daniel Aherne spiega che la neurodiversità è stata più volte paragonata alla biodiversità. Così come diverse specie di piante e animali svolgono una funzione precisa e fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio ecosistemico, la diversificazione in termini di elaborazione del pensiero è utile alla specie umana per evolversi e prosperare.
L’idea che esista un solo tipo di struttura cerebrale o stile cognitivo “giusto” e “sano” è quindi un costrutto sociale, al pari del concetto che esistano un genere, un’etnia, o un orientamento sessuale più “normali” di altri. Ne consegue che le difficoltà affrontate dalle persone neurodivergenti non derivano da cosiddette “patologie”, ma sono piuttosto il risultato diretto di squilibri di potere e dinamiche marginalizzanti.
Sommersə si muove all’interno del paradigma della neurodiversità. Così come non esistono cervelli “giusti”, non esiste nemmeno un solo modo valido di essere autisticә. Non esiste una check-list universale, né una lista di sintomi che valga per tuttə. Esistono piuttosto le nostre esperienze, a volte simili, altre radicalmente diverse.
Ti invito quindi ad attraversare e fare tuo questo spazio, lasciandoti con uno spunto finale: hai mai pensato a cosa succederebbe se cominciassimo a scrivere da noi il nostro libretto delle istruzioni, ignorando del tutto quello che ci hanno imposto?
Se ti va, puoi condividere le tue riflessioni rispondendo a questa mail o lasciando un commento. Ti ascolto.
Ci auguro che Sommersə possa diventare un taccuino per tenere traccia di un viaggio verso nuove parole, nuovi modi di stare insieme e, chissà, forse nuovi mondi.
Ci si legge presto,
Camilla
🪼Sommersə è per sua natura gratuita, e sempre lo sarà. Credo profondamente nell’accessibilità e nella condivisione libera del sapere.
Se ti è piaciuta questa newsletter, aiutami a far crescere il progetto spargendo la voce.
Se hai la possibilità di farlo, puoi sostenere il mio lavoro con una donazione su Ko-fi: ogni contributo mi aiuta a mantenere questo spazio vivo, libero e indipendente.

Member discussion