Storia di una diagnosi fallimentare
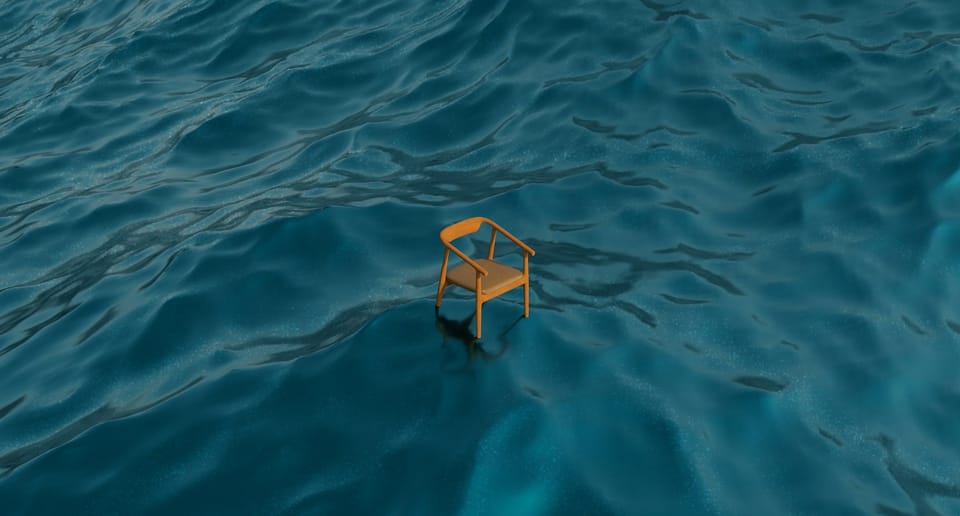
In teoria, l’idea era semplice: una diagnosi per dissipare ogni dubbio. Per smettere di oscillare come un pendolo impazzito fra la convinzione di essere autistica e la vergogna insostenibile di sentirmi una vile impostora vittima di autosuggestione.
In pratica, è stato un po’ come andare dal medico con tutti i sintomi della febbre e sentirsi dire: “40?! No, il termometro deve segnare almeno 45, stupida!”
Il mio primo tentativo di diagnosi si è concluso con un fallimento spettacolare. Ho capito, a mie spese, che lo spazio medico è ben lontano dall’essere neutro: è un dispositivo pieno di filtri, aspettative e stereotipi. E se non ti comporti come ci si aspetta che si comporti una persona autistica, semplicemente non esisti.
Volevo solo una diagnosi, non un altro trauma
Nel primo numero di questa newsletter ho raccontato come tutto è cominciato: il mio primo incontro con il mondo delle neurodivergenze, il dubbio che dietro anni di ansia e depressione potesse esserci qualcosa di più profondo, e l’ossessiva ricerca di informazioni durata mesi.
A metà fra lo shock e il sollievo di fronte a spiegazioni che davano finalmente senso a tutte le mie esperienze passate e presenti, mi sono ad un certo punto imbattuta in alcuni test che possono essere utilizzati per una prima autovalutazione: l’Autism Spectrum Quotient, il RAADS–R, il Camouflaging Autistic Traits Questionnaire e l’Aspie Quiz. Questi test non sono ovviamente strumenti diagnostici definitivi, ma danno modo di verificare se può esserci qualcosa da approfondire. Li ho compilati e ricompilati innumerevoli volte, a distanza di giorni e settimane, per scongiurare la possibilità di autosuggestione. Il mio punteggio era sistematicamente ben al di sopra della soglia che separa un cervello neurotipico da uno autistico.
A quel punto volevo la conferma finale. Volevo sentirmelo dire forte e chiaro: sei autistica, non ti sei sognata tutto. Ti sei flagellata per trent’anni perché non sapevi che il tuo cervello funzionasse diversamente. Sei autistica, e ora ci mettiamo un bel timbro ufficiale così che anche tuttә lә altrә possano finalmente capire le tue bizzarrie e renderti la vita più semplice.
Vivo all’estero, quindi rivolgermi al servizio pubblico locale era fuori discussione. Per ovvie ragioni, volevo affrontare il percorso nella mia lingua madre. Ho chiesto in giro, rivolgendomi per lo più ad altre persone neurodivergenti che avevano già ottenuto una diagnosi in Italia. Trattandosi per lo più di somministrazione di test e colloqui di approfondimento, il percorso diagnostico può essere fatto anche a distanza; ho quindi stilato una lista di possibili centri specializzati e professionistә disponibili online.
La prima botta in testa è arrivata quando ho scoperto i costi. Una diagnosi di autismo, che include un ciclo di incontri variabile da caso a caso, costa mediamente fra i 500 e i 700 euro. Per me, lavoratrice precaria e sottopagata da sempre e per sempre, significherebbe non mangiare e non pagare l’affitto per un mese. Ed è solo la diagnosi: dopo cosa succede? Dovrei forse andarmene con il mio foglio timbrato e sentirmi meglio come per magia? Ovviamente no. La diagnosi è solo l’inizio. E anche tutti i percorsi di supporto che vengono dopo costano.
Seppur con tutte queste preoccupazioni non da poco in testa, mi sono detta che valeva comunque la pena cominciare a raccogliere qualche informazione. Ho quindi fissato un appuntamento con una delle pochissime cliniche che offriva una videochiamata conoscitiva gratuita di 20 minuti.
Il giorno del fatidico appuntamento ero seduta davanti al mio portatile, tesissima. Sullo schermo è comparso un signore di mezza età, che si è presentato come l’operatore sociosanitario incaricato di fare una prima valutazione. Sono andata dritta al punto: ho spiegato che venivo da mesi di ricerche e autoanalisi, che pensavo di essere nello spettro autistico e che volevo una diagnosi.
Non dimenticherò mai il cambio repentino nell’espressione del mio interlocutore, a metà fra l’interdetto e il sorpreso: “Autistica? Tu?!”
Mi sono subito sentita avvampare, ero così imbarazzata che avrei voluto scomparire, inghiottita dal pavimento. Sono seguite domande di cui lì per lì non capivo il senso: “Vivi da sola? Riesci a prendere decisioni autonomamente? Lavori?” Ho risposto di sì, che conduco una vita apparentemente normale. Ma ciò non cancella le mie difficoltà quotidiane.
“Ho avuto a che fare con un ragazzino autistico anni fa, e non si può nemmeno lontanamente paragonare a come ti presenti tu. Nemmeno parlava, comunicavamo disegnando”, ha continuato lui.
A quel punto mi sono ammutolita, in preda alla costernazione. L’operatore ha concluso dicendomi che, se proprio mi ero fissata, avrei sempre potuto procedere con la diagnosi. Ma lui non riteneva fosse il caso.
In appena venti minuti di videochiamata sono stata etichettata come una povera pazza, una sorta di ipocondriaca in versione psichiatrica che si inventa di essere autistica pur di trovare una risposta al proprio malessere. Nei giorni successivi sono caduta in una spirale di ansia e disperazione. Mi ci è voluto del tempo per riemergere da quel buco nero. Ancora adesso, a distanza di oltre sei mesi, l’idea di rivolgermi nuovamente a qualche professionista per una diagnosi mi provoca moltissima agitazione.
Diagnosi e genere
Consensus è una piattaforma specializzata che rende accessibili ricerche accademiche di ogni tipo. È possibile formulare una domanda specifica, e il motore di ricerca troverà una risposta basandosi sugli studi recenti più rilevanti. Ho chiesto se gli attuali criteri diagnostici contenuti nel DSM-5 e utilizzati per lo spettro autistico siano ugualmente efficaci per le donne. Ecco la risposta:

Sulla base delle nove ricerche analizzate dalla piattaforma, i parametri diagnostici in uso non sono affatto efficaci quando si tratta di pazienti donne o socializzate come donne.
Stando ai dati al momento disponibili, la proporzione della diagnosi di autismo fra popolazione maschile e femminile è di 4:1. Tuttavia, secondo uno studio condotto nel 2017, la reale proporzione sarebbe più vicina a 3:1.
Il problema risiede nel modo in cui i criteri diagnostici sono stati sviluppati. La stragrande maggioranza degli studi sono stati infatti condotti su individui di genere maschile, elaborando di conseguenza un modello tarato su parametri che ignorano del tutto l’esperienza autistica femminile.
Solo recentemente si è cominciato a parlare di un "fenotipo autistico femminile" con caratteristiche proprie, che si discostano dal modello maschile predominante. Le persone socializzate come donne sono soggette ad una pressione sociale molto maggiore rispetto agli individui di genere maschile. Già in tenera età, sono indotte a conformarsi a determinati standard comportamentali: compostezza, educazione, gentilezza, disponibilità. Ciò le porta a sviluppare tecniche di mascheramento molto raffinate, che possono rendere difficile individuare l’autismo dall’esterno.
Ma ciò non significa che le difficoltà di adattamento e la sofferenza emotiva siano minori. Al contrario: la costante autocensura e l’inarrestabile sforzo profuso nel cercare di adattarsi a schemi e ritmi non adatti al proprio funzionamento causano spesso problemi di salute mentale molto pervasivi, che vanno ad aggiungersi alle già presenti difficoltà.
Ed eccoci quindi al paradosso. Abbiamo meno possibilità già in partenza di ricevere una diagnosi per via di un sistema diagnostico fortemente sbilanciato – di stampo patriarcale, direi. Per questa ragione, prive di risposte e strumenti adeguati per capirci e gestirci, siamo più soggette a problemi di salute mentale. Quando ci rivolgiamo a dellә professionistә – spesso in età adulta, quando ormai siamo sull’orlo del baratro –, le nostre diagnosi si concentrano di conseguenza su ciò che è più evidente: ansia, depressione e così via. E le soluzioni offerte risultano inefficaci, perché non si arriva mai ad affrontare la vera radice del problema. È un cortocircuito senza fine.
Io stessa sono stata in terapia per diverso tempo, ma nessunә dellә miә terapistә ha mai anche solo vagamente accennato alla possibilità che potessi essere neurodivergente. Non facevo veri progressi. Avevo sempre la sensazione di girare in tondo senza sosta, senza mai risolvere nulla.
Non biasimo lә diversә professionistә che nel corso del tempo mi hanno seguita. Anche loro, d’altra parte, si sono formatә all’interno di un paradigma medico asimmetrico che, ignorando l’esperienza di tutte quelle soggettività (non solo femminili, ma anche maschili e non binarie) che non rispecchiano i parametri più patologizzanti, crea una sacca di invisibilizzatә. Di sommersә. Persone come me, troppo poco neurotipiche per adattarsi con successo, ma anche troppo poco autistiche per essere prese sul serio dalla psichiatria.
Diagnosi e capitalismo
Come accennato sopra, a questo quadro desolante si aggiunge l’ostacolo legato ai costi. La mia esperienza non rappresenta un’eccezione dovuta al fatto che, per ragioni logistiche, mi sono necessariamente dovuta rivolgere al settore privato.
In Italia, i servizi dedicati alle neurodivergenze all’interno del settore pubblico sono pochi, saturi, e spesso funzionano male. Le liste d’attesa sono lunghissime. Ne ha parlato Anna Castiglioni nella newsletter Atipiche, dedicata all’ADHD, raccontando quanto sia ancora più complicato trovare professionistә specializzatә e percorsi diagnostici per adultә nel settore pubblico.
Sappiamo bene che capitalismo è sinonimo di privatizzazione. Nel caso della salute mentale, la privatizzazione non riguarda solo l’aspetto economico, ma anche quello sociale: il malessere psicologico è una responsabilità – se non una colpa – individuale. Le cause esterne, sistemiche, vengono minimizzate. Sono io quella “rotta”, è il mio cervello a non funzionare come si deve. Di conseguenza, sono sempre io a dovermi addossare la responsabilità e l’onere economico di “aggiustarmi”. La collettività se ne lava le mani, e la salute mentale passa dall’essere un diritto fondamentale a un mero servizio a pagamento riservato solo a chi se lo può permettere.
Ed eccoci, di nuovo, ad un altro paradosso. L’autismo non è una “malattia” da cui si “guarisce”. È una conformazione cerebrale differente, il cui funzionamento cozza con un mondo progettato a misura di cervello neurotipico, e che quindi richiede potenzialmente un certo grado di supporto a vita. Supporto che è però talvolta vincolato all’avere una diagnosi, spesso inaccessibile in termini di costi.
Specialmente quando parliamo di persone autistiche che non rispecchiano i criteri diagnostici attuali, la diagnosi può essere l’unico strumento utile per ottenere la validazione necessaria a chiedere aggiustamenti nella vita lavorativa, campo in cui molte persone autistiche affrontano problemi significativi.
Prendiamo un esempio concreto, che rispecchia molto la mia esperienza personale. Se sei autisticә ma non hai una diagnosi ufficiale, è molto probabile che sul lavoro nessuno prenda sul serio le tue difficoltà.
Il rumore costante in ufficio ti sfinisce? Sei troppo sensibile.
Ti perdi nei cambiamenti improvvisi? Devi imparare ad essere più flessibile.
Ti serve tempo per ricaricarti dopo un’interazione intensa? Non sei abbastanza motivatә.
Senza una diagnosi, ogni tua richiesta rischia di essere letta come un capriccio. Non esistono aggiustamenti, né accomodamenti. Il risultato? Ti esaurisci, ti ammali, ti ritiri. Oppure vieni licenziatә perché “non sei abbastanza performante”. E quando perdi il lavoro, perdi anche la possibilità economica di ottenere quella diagnosi che forse ti avrebbe potuto salvare dal burnout, dallo stigma, dall’esclusione.
È un circolo vizioso. Un loop capitalistico perfetto: se non hai soldi non puoi avere una diagnosi, ma senza diagnosi rischi di non riuscire a lavorare abbastanza da avere soldi.
In questo senso, la diagnosi diventa una questione di classe. Non si tratta solo di riconoscimento clinico: è un biglietto per l'accesso a risorse, tutele, comprensione. E se non puoi permettertelo, resti tagliatə fuori.
La diagnosi non basta
La disabilità è relazionale. Non è innata, non è un “deficit” meramente individuale, ma dipende in gran parte dalla struttura del contesto ambientale e sociale. Se il 90% della popolazione mondiale si muovesse in sedia a rotelle e tutto – città, mezzi pubblici, spazi privati e comuni – fosse progettato sulla base di questa caratteristica, la disabilità motoria non esisterebbe. Le persone non sarebbero comunque in grado di camminare sulle proprie gambe, certo, ma non esisterebbe quel tipo di disabilitazione imposta da un contesto pieno di barriere architettoniche.
Lo stesso vale per la disabilitazione che deriva dall’essere neurodivergente. Se il problema è relazionale, anche le soluzioni devono essere pensate in ottica relazionale. Bisogna chiamare in cause le responsabilità di tuttә: per cambiare un sistema clinico patologizzante di stampo patriarcale, e per scardinare un sistema capitalista che ci impedisce di esistere pienamente se non impariamo a performare una normalità che non ci appartiene.
È tempo di smettere di delegare la responsabilità del cambiamento soltanto a chi subisce. Serve una trasformazione collettiva: nei servizi, nei linguaggi, negli spazi, nelle relazioni.
Non si tratta di “includere” chi è consideratə fuori norma, ma di ripensare da zero le regole del gioco. Perché una società che non lascia indietro nessunə non si costruisce con l’empatia individuale, ma con giustizia strutturale.
Grazie per essere statә con me fino a qui. Se ti va, puoi condividere le tue riflessioni rispondendo a questa mail o lasciando un commento.
Ci si legge presto,
Camilla
🪼Sommersə è per sua natura gratuita, e sempre lo sarà. Credo profondamente nell’accessibilità e nella condivisione libera del sapere.
Se ti è piaciuta questa newsletter, aiutami a far crescere il progetto spargendo la voce.
Se hai la possibilità di farlo, puoi sostenere il mio lavoro con una donazione su Ko-fi: ogni contributo mi aiuta a mantenere questo spazio vivo, libero e indipendente.

Member discussion